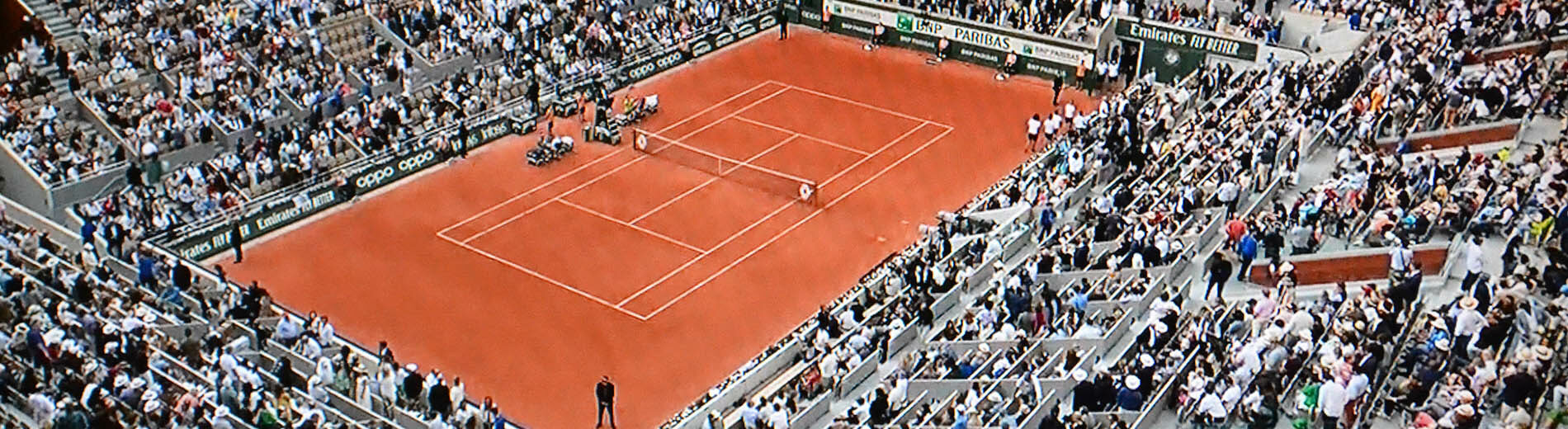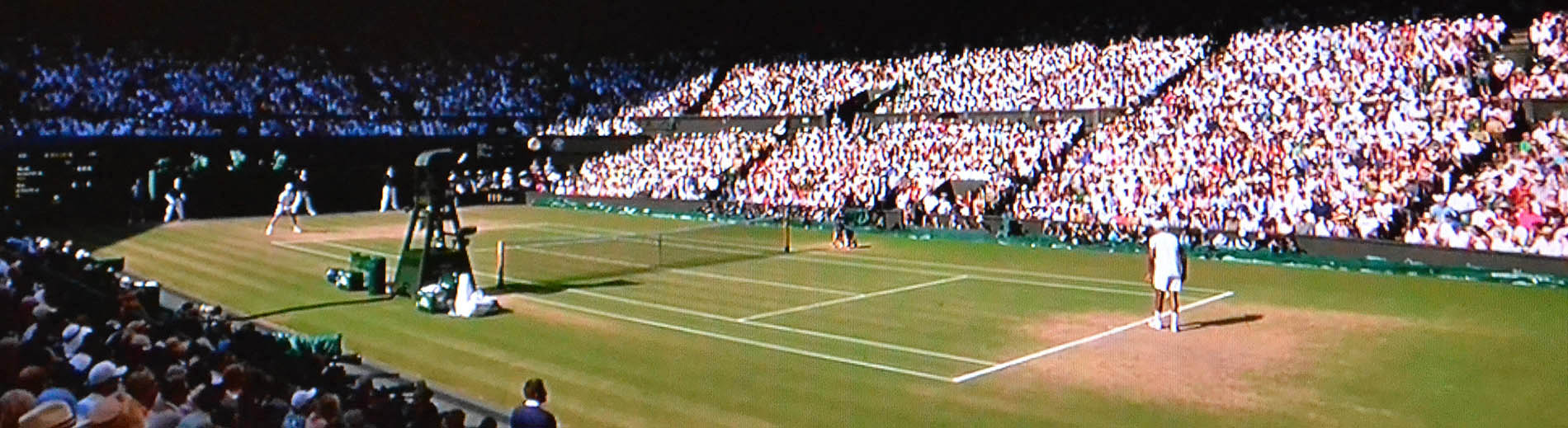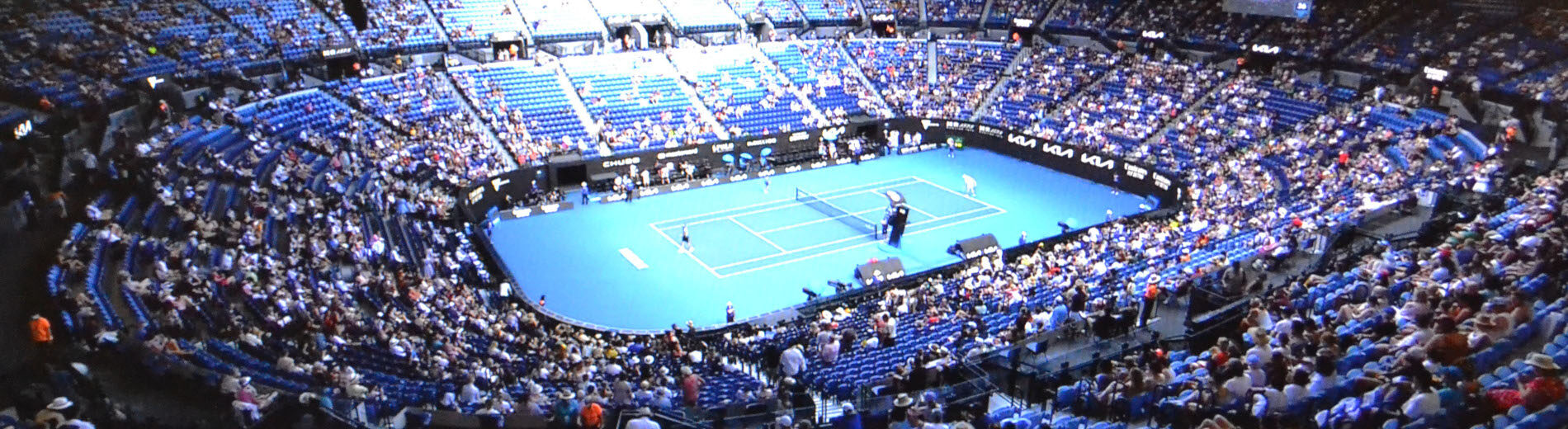Quella tra Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis, tra loro molto amici e compagni di squadra fin da quando erano ragazzi, è stata la classica partita dove il risultato non aveva valore. Sapevamo delle condizioni fisiche di Juan Martin, non speravamo che potesse giocare meglio. Non era la partita del ritorno ma quella dell’addio.
Il lato sportivo – gli errori non forzati, il servizio che non funzionava, la fatica evidente nel muoversi velocemente, anche se qualche gran colpo si è visto – ha lasciato il posto a quello umano e a ciò che la Torre di Tandil ha rappresentato per il tennis mondiale.

A livello Major ha vinto solo a Flushing Meadows quando non aveva ancora 21 anni ma se non fosse stato così fragile fisicamente, lui che è alto quasi due metri, non credo che Nadal, Federer e Djokovic avrebbero vinto 61 titoli Slam.
E’ il tennista che ha avuto più infortuni ma è sempre stato capace di rialzarsi, di provarci ancora. E’ stato il giocatore che si è ribellato al destino, capace di chiedere sempre di più a se stesso. Un esempio unico riconosciuto da tutti, tifosi di tennis e colleghi, e da tutti apprezzato, stimato, amato.
Ieri in una serata di festa e di lacrime, ha lasciato. L’ha fatto davanti alla sua gente e non su un palcoscenico importante che spesso l’ha visto protagonista. Non conta se giocherà a Rio dove nel 2016 arrivò in finale alle Olimpiadi. Forse sarebbe meglio che non lo facesse.
Sarebbe un addio che non si merita. Nelle dichiarazioni del dopo match ha lasciato dubbi sulla sua partecipazione al torneo brasiliano. Non ho più energie per continuare a combattere, il dolore al ginocchio è troppo forte, ora devo pensare a guarire per avere una vita normale.
Non vogliamo supplizi per un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nel tennis degli ultimi 15 anni. Che sia egoista, che pensi a se stesso. Le immagini delle sue gesta rimarranno comunque e sempre con noi. Non c’è bisogno di rientrare in campo.